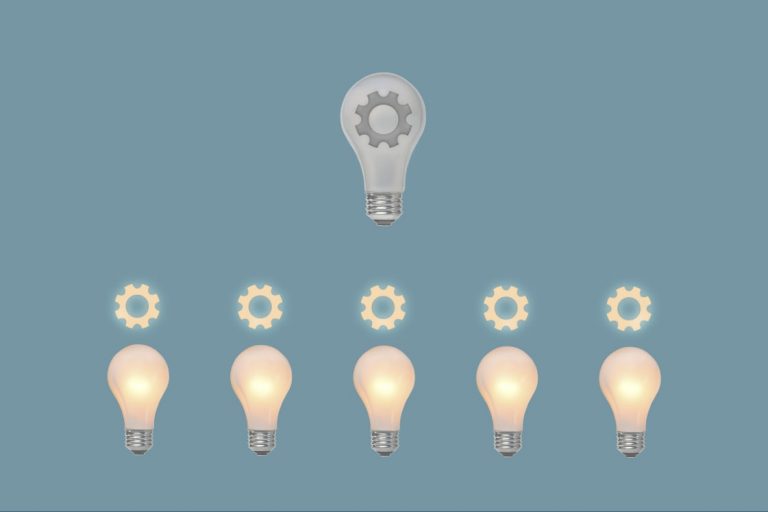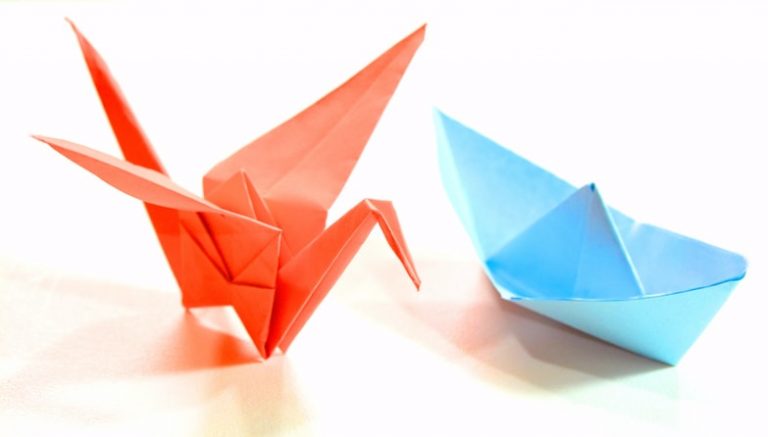Da 1984 a Black Mirror, ecco perché oggi (più che mai) abbiamo bisogno della distopia

La parola utopia viene dal greco, composta da ou (non) e topos (luogo), a indicare dunque un luogo che non esiste, che non si trova sulle cartine: quello che Tommaso Moro s’inventò nel 1516 nel suo libro L’utopia appunto, un trattato che, sulla scia dei dialoghi platonici, immaginava uno stato perfettamente funzionante. Perché la pronuncia inglese di u- è simile a un altro prefisso greco, eu (buono): da allora la parola divenne sinonimo di opera letteraria che propone un modello di governo ideale, positivo ma ancora irrealizzato, forse irrealizzabile.
Un altro esempio classico è La città del sole di Tommaso Campanella (1602) ma si sa che dove c’è il sole c’è anche l’ombra: dopo qualche secolo dalla nascita dell’utopia venne alla luce anche la distopia. Man mano che il pensiero moderno si avviava alla contemporaneità, la prospettiva del futuro non si tingeva solo di progressismo e di speranza, ma anche di disillusione e paure. E se l’inizio del Novecento, con Il mondo nuovo di Aldous Huxley (1935), 1984 di George Orwell (1949) o Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (1953), sembrava essere stata l’epoca classica della distopia letteraria, oggi ci troviamo di fronte a un nuovo momento molto florido per questo genere.
In un articolo apparso l’estate scorsa sul New Yorker, Jill Lepore, professoressa di storia a Harvard, parla di una nuova “epoca d’oro della narrativa distopica”: basti solo pensare al rinnovato successo de Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, divenuto una serie tv acclamatissima come The Handmaid’s Tale, ma anche a opere per ragazzi come Hunger Games e Ready Player One, in cui si immaginano mondi devastati da cataclismi climatici e guerre civili. Questi ultimi, in particolare, si rivolgono secondo Lepore “a lettori che si sentono traditi da un mondo che pareva molto più accattivante quando erano un po’ più giovani”.
È indubbio che questo moltiplicarsi di titoli distopici, che appunto dipingono un futuro in cui a dominare solo le istanze più catastrofiche e sovversive, sia un chiaro riflesso della nostra epoca così sconquassata da contraddizioni e incertezze. Lepore cita un fatto oggettivo a prova di questo: immediatamente dopo l’avvento di Trump negli Stati Uniti e i continui riferimenti del suo staff agli alternative facts, i “fatti alternativi”, sono aumentate esponenzialmente le vendite di 1984 di Orwell, romanzo che inventò il concetto di Grande Fratello e introdusse la neolingua, un idioma controllato politicamente per alterare la realtà.
Di cosa trattano le distopie di oggi? Il racconto dell’ancella di Atwood (1985) parla di un governo autoritario che priva dei diritti civili le donne e le sottomette come puri strumenti riproduttivi. Il complotto contro l’America di Philip Roth (2004) immagina una dimensione ucronica in cui gli Stati Uniti sono caduti nelle mani dei nazisti. Il cerchio di Dave Eggers (2013) è ambientato in un mondo in cui un social network diventa una specie di culto pervasivo e senza scampo. Parlando di letteratura visiva, le quattro stagioni di Black Mirror (2011-presente) mettono in campo i vari modi in cui la tecnologia frustra la nostra umanità. Politica, tecnologia, ambiente, diritti civili: tutte queste narrazioni sono come lo specchio deformante delle nostre paure più profonde ma anche dei temi su cui la nostra opinione pubblica si divide più ferocemente.
Ma sono davvero utili, dunque, le distopie? Il genere letterario dell’utopia nasceva non solo come esercizio dialettico e filosofico ma anche come proposta effettiva di governo (Moro stesso, prima di cadere in disgrazia, era consigliere del re d’Inghilterra Enrico VIII). La distopia, invece, nasce come una dissertazione che – sconfinando spesso in un certo tipo di fantascienza sociopolitica – vuole mettere in guardia sulle possibili aberrazioni del nostro progresso. C’è chi sostiene che sia solo un modo pessimista per vedere la realtà e dunque un esercizio intellettualistico che gioca sulla radicalizzazione dei temi.
In effetti è una questione di pessimismo e ottimismo: ancora Lepore sottolinea come le distopie di oggi fioriscano sul terreno divenuto improvvisamente sterile dopo gli anni della fertile retorica della speranza di Obama con Yes We Can o di certe fiducie spassionate nei confronti di fattori tecnologici, digitali, consumistici. Ma se serve l’ottimismo, vien da dire, anche un certo tipo di sguardo più pensoso e dubbioso sulla realtà ha la sua funzione: da una parte perché, appunto, ci mantiene in allerta e dall’altra perché ci segnala problemi che altrimenti non avremmo modo di relativizzare.
Uno dei romanzi più acclamati del 2017, Le ragazze elettriche di Naomi Alderman, era una specie di distopia in cui le donne adolescenti iniziano a sviluppare il potere di rilasciare scariche elettriche, soprattutto se minacciate di violenza o di stupro, e prendono così il potere facendo dimenticare all’umanità di essere un tempo stata dominata dai maschi. Ovviamente si parla di eccessi, ma in un momento storico in cui i movimenti femministi riprendono piede con rinnovato vigore dopo gli scandali sessuali di questi mesi, questa riflessione romanzata ribalta la scena e mette in mostra tutti i cortocircuiti di una società completamente maschilista mostrandone una completamente femminista.
Le distopie di oggi, oltre a fornire dunque degli strumenti accattivanti e stimolanti di decifrazione del reale, servono anche a un altro scopo: a far sentire la propria voce, a formulare – sebbene camuffato nella fiction – una sorta di dissenso critico nei confronti di molti fenomeni, anche quelli su cui ci pare di non poter agire. La sfortunata ma determinata protagonista di The Handmaid’s Tale, Difred, a un certo punto dice: “Prima ero addormentata. Ecco come abbiamo lasciato succedere tutto ciò”. Le distopie sono solo libri, certo, ma ci aiutano a non addormentarci, a tenere gli occhi aperti. Forse ci insegnano qualcosa, molto più probabilmente ci aiutano a sentirci meno in colpa.