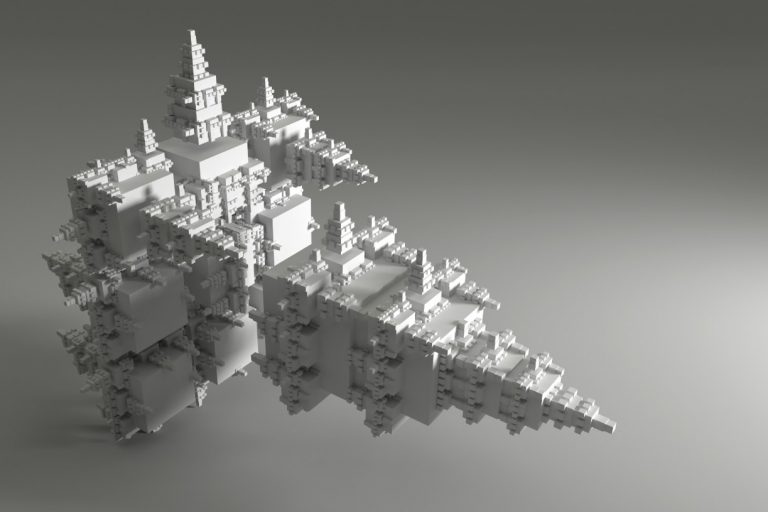La ricerca italiana fa flop? Diamo più diritti (e doveri) alle Università e apriamo alle imprese

È possibile dire che le università e gli altri istituti di ricerca italiani stiano dando un contributo rilevante ai processi di innovazione del nostro Paese?
Se lo chiede il recente Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica italiana, riportando una serie di dati rilevanti sull’impegno delle università nel trasferimento di innovazione al mondo produttivo, come ad esempio il numero di brevetti realizzati e licenziati all’industria o le nuove imprese innovative costituite, gli spin-off accademici.
Ma concretamente, quanto rilevante è l’apporto della ricerca scientifica nello sviluppo di prodotti e processi innovativi che trovano sbocco sul mercato e sono oggetto di commercializzazione da parte delle imprese?
Se si compara l’Italia con la realtà statunitense e con quella di alcuni Paesi del nord Europa la situazione risulta sfavorevole per il nostro Paese: infatti la capacità della ricerca pubblica di trasformare i propri risultati in opportunità di business per le imprese fatica oggi ad emergere. Eppure alcuni casi di successo sono ravvisabili anche da noi.
Molmed, società di biotecnologie mediche focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro è uno dei casi di successo originati dalla ricerca del San Raffaele di Milano.
È recente la notizia secondo la quale l’Europa avrebbe concesso l’autorizzazione per l’immissione in commercio di una terapia avanzata a base di cellule staminali in grado di restituire la vista a pazienti con gravi ustioni della cornea. La nuova terapia è stata sviluppata nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Lasciando il contesto farmaceutico, io stesso ho seguito l’acquisizione da parte di una multinazionale di un’innovativa soluzione sviluppata al Politecnico di Milano nell’ambito dei sistemi di telecomunicazioni a femtocelle: l’invenzione permetterà di ridefinire completamente l’architettura del sistema a femtocelle con notevoli vantaggi in termini di costi, durata dei dispositivi che non risentono dell’obsolescenza dei protocolli radio e versatilità del dispositivo proposto denominato Analog-to-Analog converter.
Al di là del fatto che sussistano evidenti differenze di scala nella performance dei vari Paesi, ho l’impressione che ci sia ancora qualche difficoltà in Italia a livello di percezione generale.
Forse comunichiamo poco i successi che conseguiamo? Certamente. Il problema però è anche che non riusciamo a tener traccia di tutti i processi di innovazione innescati dalle università né tantomeno ad innescare tutti i processi di innovazione che avrebbero delle potenzialità di successo.
Uno dei motivi è sicuramente il “professor’s privilege” quella norma cioè, esistente ormai solo in Italia e in Svezia, che attribuisce, in linea di principio, la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori universitari ai ricercatori stessi invece che alle università.
Tale disposizione pone una serie di ostacoli sia sul piano della comunicabilità dei risultati ottenuti, sia su quello della sfruttabilità dei risultati stessi. Il ricercatore da solo ha un accesso limitato al network dei media e non sempre ha tempo e strumenti per valutare le possibilità di sfruttamento economico della propria ricerca: spesso non percepisce le opportunità o non prova a coglierle.
Se poi aggiungiamo la visione ancora diffusa, e a tratti un po’ ideologica, per cui il ricercatore pubblico non dovrebbe avere a che fare con le imprese, tacciate di condizionare la libertà di ricerca, bensì dovrebbe limitarsi all’esplorazione e divulgazione della conoscenza generata, allora forse sarà più comprensibile il motivo per cui l’intento del legislatore italiano di stimolare – attraverso il “professor’s privilege” – l’iniziativa del singolo non ha centrato l’obiettivo.
Non è rischioso confidare nello spirito imprenditoriale di colui il quale legittimamente intende portare avanti il proprio lavoro di libero ricercatore, ma non necessariamente è dotato di propensione all’imprenditorialità?
In tale scenario gli sforzi degli atenei di approntare strutture dedicate al trasferimento tecnologico (Incubatori, Technology Transfer Offices ecc.) rischieranno sempre di avere un impatto limitato.
A dispetto delle taumaturgiche soluzioni presentate negli anni si potrebbe lavorare sulla falsa riga di ciò che è stato fatto negli USA e in gran parte dell’Europa per approntare almeno alcune condizioni di contesto basilari per poter operare. L’alternativa all’attuale sistema potrebbe essere molto semplice e orientata ai seguenti principi:
- i diritti delle invenzioni realizzate dal ricercatore pubblico – che è pur sempre un dipendente dell’istituzione di ricerca – vengano assegnati all’ente che deve avere la responsabilità di intraprendere azioni idonee a valorizzare economicamente tali invenzioni in un dato frame temporale (pena la retrocessione dei diritti all’inventore);
- il ricercatore sia responsabilizzato nella comunicazione al proprio ente (disclosure) dei risultati della ricerca suscettibili di uno sviluppo applicativo (poiché se non c’è comunicazione, non c’è consapevolezza e quindi non si agisce);
- le strutture di supporto (Incubatori e Technology Transfer Office) facciano il loro lavoro, cioè forniscano strumenti di valutazione, management e networking per lo sviluppo del progetto applicativo;
- il ricercatore rimanga il pivot del progetto e a lui vadano buona parte dei ritorni economici, in parte a remunerare l’attività svolta e in parte ad incentivare future iniziative.
In questo modo ciascuno degli attori coinvolti ha il proprio ruolo e si coopera per un risultato condiviso.
Dobbiamo considerare questa come una soluzione lineare, professionale ed efficace? I risultati degli altri Paesi sembrerebbero confermarlo.